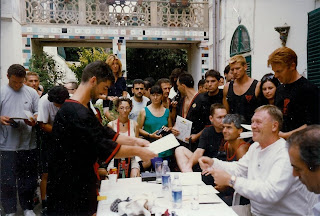Oggi incontriamo il Maestro Riccardo Vacirca, fondatore della WingTchun Escrima Academy (WEAC).
Ci puoi dire qualcosa sulla tua vita? Quando hai cominciato a praticare le AM?
Ho iniziato lo studio delle AM all’età di 13 anni, in una palestra (saluto il M° Franco Cucinotta) dove il motto era “botte da orbi”, e dove, grazie ai tempi che furono, ebbi la possibilità di apprezzare ed apprendere il concetto dello spirito marziale, una forma di ascetismo, dedizione maniacale per lo sviluppo di abilità tecnico-fisiche, e parallelamente, un equilibrato “odio” per nozioni e nozionisti (che sempre più oggi infestano le AM……ma questa è un’altra storia…)
Con chi iniziasti a studiare il Wing Chun?
Anche se già si praticavano alcuni esercizi di wc del M° Narciso Pula, il primo vero contatto con il WC fu con il Si-Fu M. Fries, siamo intorno all’85, sempre nella stessa palestra, grazie alla passione e all’intelligenza del M° Cucinotta, che in quel periodo era sempre pronto a mettere in discussione e sperimentare vari stili e maestri, come Chang Dsu Yao, Pasotti ed altri. In quell’epoca di miti marziali di vario genere, la pragmaticità del WC fu talmente traumatica che il mio “bambino emozionale” vibrò così tanto da impedirmi di percepirlo e praticarlo con le dovue attenzioni (una forma di viltà adolescenziale che me lo fece percepire come stile minore, quindi, 3-4 ore settimanali le ritenevo sufficienti), anzi, mi fece riversare ancor più energie nello Shaolin, per un 15enne far sibilare le armi, compiere evoluzioni e fare due passi e mezzo su una parete…non ha prezzo!
Solo nel 91, dopo migliaia d’ore di allenamento e verifiche pratiche, si esaurirono l’energie di quel “bastardo” di bambino emozionale, e cominciai la “mia pratica maniacale” nel WC
Chi sono stati i tuoi maestri nel passato? E chi è il tuo attuale Maestro?
Molti sono stati i miei Maestri da cui ritengo di aver preso molto, anche se con alcuni il rapporto è stato di sole decine d’ore, con altri centinaia e con alcuni migliaia d’ore, sia in stage, che, soprattutto, con ore private. Come, per esempio, nel periodo, durato circa 10 anni, in cui praticamente vivevo a Livorno almeno sette settimane all’anno per 30 ore settimanali di pratica con vari personaggi importanti delle AM, come Leung Ting, K.R.Kernspecht, E. Botzepe, Tassos, Avci, il grande R.Latosa, B.Newman per citare forse i più famosi di quel periodo. E poi il periodo, a cui dedico una menzione onorevole, quello con i Maestri Smart e Prosenica, allievi di Leung Ting anche prima di Kernspecht, dai quali ho potuto apprendere delle piccole varianti su programmi e nozioni, che confermarono la mia, già consolidata, idea sull’errata interpretazione del modo di tenere ed allenare la struttura usata dal wc. Struttura, che è un “sine qua non”, senza la quale, cioè, non si possono eseguire i vari programmi, neanche in un semplice sparring civile non collaborativo. Senza la quale, il wc si trasforma da un’arte marziale, ad un complicato metodo di autodifesa, dove, sempre e solo il più forte vince il più debole.
Ho ricevuto molti insegnamenti in merito, e non solo nell’ambito marziale. Infatti, alcune chiavi di lettura le ho acquisite da veri Maestri in campi come il recupero funzionale di abilità motorie, in correttiva, in biomeccanica, nel campo riabilitativo, in laboratori funzionali dove le opinioni, anche di personaggi con una “presunta” certificazione, venivano e vengono messe in discussione con prove sperimentali che non lasciano spazio alle varie teorizzazioni. Chiavi di lettura, che poi riversate nello studio delle AM mi hanno permesso di decodificare dei principi ed interpretare delle direttive (...tipo la corretta postura per eseguire e dare efficacia universale alle tecniche), che forse (e vi assicuro, solo apparentemente) sembrano discostarsi un pochino dalle interpretazioni ritenute “tradizionalmente classiche”, ma, per chi riesce ad applicarle nella pratica, danno effetti dirompenti e universali, e soprattutto non opinabili, per intenderci, come la maggiore efficacia della tecnica fosbury, nella disciplina atletica del salto in alto, rispetto a quella a forbici o ventrale, la stessa persona, chiaramente se allenata, ottiene risultati superiori, “sempre”.
In questo periodo, le mie attenzioni ed energie sono rivolte a questo perfezionamento del rendimento biomeccanico, oggi sono a poco più di un 40% del suo potenziale, e la mia capacità di creare pressione nel chi-sao, senza perdere fluidità e quindi velocità, è più che raddoppiata, e quasi nessuno dei maestri che vedo in circolazione è in grado di pareggiare questo tipo di abilità senza l’uso di un’evidente e superiore mole fisica, cosa che io assolutamente non possiedo. Solo quando avrò raggiunto un livello a me soddisfacente in questa caratteristica, comincerò a cercare chi vorrà e potrà perfezionare i programmi da me conosciuti, che comprendono le sezioni delle tre forme, le sezioni e strategie del mok yan chong, il mostruoso chi-gerk e l’abilità nelle armi.
Come si può diventare Si-Fu nella tua associazione?
Semplicemente dimostrando su carta e sul campo di possedere abilità, conoscenza e qualità idonee per tale nomina. Visto che non si pagano tasse di alcun tipo, non si pagano i programmi, di nessun livello, l’unico modo per diventare Si-Fu è il duro lavoro (Kung-Fu), che, è l’unica cosa che faccio pagare.
Quindi non sono io che lo decido, ma insieme, constatando di essere realmente un Si-Fu, e non di credere di esserlo per il solo bagaglio nozionistico, perché si conoscono forme, sezioni e loro applicazioni. Conoscere non è sufficiente, bisogna mettere in pratica, desiderare non è abbastanza, bisogna fare.
Quante ore ti alleni al giorno?
Senza considerare quelle dove insegno, alleno e gli sparring dove vengo picchiato, quindi contando solo quelle a mio uso e consumo, circa 3 al dì in questo periodo, ma, guardando i diari d’allenamento di qualche anno fa, risulta una media su 365 giorni/anno di quasi 7 ore.
Hai mai combattuto in contesti sportivi?Quando, dove e con che risultati?
Il primo anno, quindi ’83-’84, con l’allora Tao Club, partecipammo ad alcune manifestazioni sportive, soprattutto a Roma, ma, nel marasma generale di allora, con federazioni che nascevano e morivano, anche nell’arco di mesi, smettemmo abbastanza presto di parteciparvi, la realtà del nostro scantinato era molto più dura. Comunque, in tutte le manifestazioni a cui ho partecipato, non ricordo di aver mai perso, ma potrebbe dire la stessa cosa chiunque altro, visto la realtà dell’epoca. Molti miti si sono creati così.
Quante ore a settimana dovrebbe praticare uno studente per progredire in maniera seria?
La cosa più importante è la qualità…non basta esercitarsi quotidianamente, se lo si fa in maniera sbagliata non si raggiunge mai lo scopo.
Comunque, all’inizio possono bastare 7 ore settimanali, poi, come tutte le cose, più se ne fanno meglio è. La cosa più efficace, però, è la proporzione delle ore dedicate ai vari aspetti.
Volendo ridurre solo a tre aspetti essenziali la pratica dell’arte marziale:
1) l’aspetto posturale (e anche in questo caso vale l’ultima frase della domanda precedente, infatti, molti atteggiamenti, posture e posizioni che ci sono arrivate, insegnate e praticate, non dovrebbero neanche esistere, sono mediocri interpretazioni, a voi stabilire se per convenienza o per mediocre intelligenza, dove, per esempio, il dire ”dentro o fuori” di un segmento corporeo, veniva scritto e usato indiscriminatamente al posto di: “pronazione e supinazione”, ”inversione-eversione”, ”rotazione interna o esterna” o semplicemente ”dentro o fuori”. Si doveva essere gran fortunati per indovinare la giusta, anzi no, il più efficace atteggiamento in una catena cinetica.
2) L’aspetto fisico-performante
3) L’aspetto tecnico-nozionistico
La giusta proporzione si dovrebbe aggirare intorno ad un 40-30-30, quindi solo il 30% dedicato all’aspetto tecnico-nozionistico.
Solo un vero esperto, un maestro si può permettere di arrivare ad un 50% delle ore dedicate al solo aspetto tecnico-nozionistico.
Molte scuole puntano troppo sul “solo” aspetto tecnico, il loro unico e possibile obbiettivo è l’aspetto commerciale.
Il buon vecchio e fruttuoso wing chun da salotto
Cosa ne pensi degli altri Si-Fu e dei loro metodi di insegnamento, nelle altre associazioni e famiglie di Wing Chun?
C’è da dire che il significato della parola Si-Fu, oggi, è completamente cambiato. Una volta, ed io sono rimasto, forse troppo legato a questo significato, il Si-Fu, era una persona con capacità e abilità certe e comprovate. Capace di insegnare, cioè, capace di far scoprire come interpretare. Non idoneo, però, per successi commerciali.
Oggi il Si-Fu è anche e soprattutto colui che possiede “la sola” conoscenza nozionistica, capace di possibili e ottimi successi commerciali.
Il conoscere e il ripetere, concetti di filosofia, arte della guerra, biomeccanica (chi-kung), sono alla portata di tutti, eppure, il 90% delle scuole di WC, ma più in generale, le scuole di AM, anche se si differenziano per tecniche e posture, non hanno niente di più del forte che sconfigge il debole e del veloce che sconfigge il lento.
E questo, non essendo un'opinione, ma realtà oggettiva, fa pensare che, in un “non ben noto” momento storico, qualcuno, o meglio alcuni, abbiano tralasciato volontariamente, o criptato, il corretto metodo per interpretare quest’arte nel modo più funzionale, in modo tale da permettere anche a chi non è in possesso di una fisicità e atleticità rilevante una degna e reale efficacia (anche qui, a voi la scelta se questo è avvenuto per vantaggi personali, o perché, la locuzione latina”margaritas ante porcos” cioè, perle ai porci, abbia trovato un ampio e giusto campo fertile).
Possiamo sapere la differenza tra il tuo WC e le altre interpretazioni?
Senza usare inutili giri di parole, direi senza dubbi la struttura.
Mi riferisco alla postura, all’idea del san ying senza la quale anche il wc diventa il solito metodo dove chi possiede maggiore mole fisica e capacità atletico-prestative risulta sempre in assoluto vantaggio.
Il wc supera di gran lunga qualsiasi altro sistema in numero di opinioni, quindi c’è qualcosa che non quadra.
E quello che non quadra è appunto l’interpretazione che vari individui danno alle solite e giuste direttive sul come costruire e, in un secondo tempo, muovere, questa benedetta struttura, il nostro corpo.
Neanche troppo tempo fa, ai primi del 900 il “nostro” corpo umano poteva elevare, alzare, abbassare, roteare, flettere, piegare, estendere, divaricare, mettere dentro e fuori, oggi, grazie a quell’esperieze e alla scienza, lo stesso corpo umano può ora anche addurre, abdurre, intraruotare, extra ruotare, pronare, supinare, etc.
Provate ora a descrivere un semplice atto motorio o una complessa catena cinetica con le informazioni e i termini dei primi del 900. Quante interpretazioni motorie dello stesso movimento, secondo voi, possono venir fuori?
Pensando al modo epico-leggendario e le allegorie usate dalla letteratura cinese per rappresentare anche le cose più semplici ed umili, si può intuire il perché di questa moltitudine di modelli presente oggi, considerando che ognuno di noi interpreta le informazioni in relazione al proprio vissuto motorio e psicologico. Alimento continuo per dispute attorno alle parole (è facile parlare di principi) invece che andare ai fatti (difficile dimostrare e insegnare un principio)
Pensate al chi-kung, potenza del respiro, prima di tutto, cosa intendevano dire i vecchi maestri (?), e poi, quali dovrebbero essere i vantaggi a cui aspirare da tale pratica (?), e se ci sono concreti vantaggi, possono essere raggiunti da chiunque si alleni in tale pratica (?).
Quanti praticano o hanno praticato il chi-kung, quanti hanno acquisito e sono in grado di dimostrare gli effetti praticamente, non con opinioni. Le sole opinioni servono solo a vili e mediocri.
Il wc rappresenta una delle ultime evoluzioni dei metodi di combattimento, infatti, a differenza di stili più “tradizionali” e antichi, che usano posture e tecniche più ampie e tendenzialmente più muscolari, il wc ha evoluto reazioni, movimenti piccoli, corti ed economici, movimenti che però, per essere efficaci devono essere eseguiti con ben precisi presupposti posturali, indispensabili per dare pesantezza e potenza, presupposti che il wc da per scontato che siano già in nostro possesso e invece non è affatto così.
Questo è il motivo per il quale, durante allenamenti non collaborativi, molti si vedono obbligati ad allargare le proprie posizioni per trovare maggior stabilità e forza. In realtà nel corpo a corpo, l’apertura delle gambe non deve essere più larga del proprio bacino per ovvi motivi dinamici (il chi-gerk insegna). Le braccia, che al contatto di quelle del partner, tengono angoli troppo aperti, come non si vede in nessuna forma, infatti, quasi mai l’angolo al gomito deve superare i 120° (la siu-nim-tao insegna).
Il problema è che normalmente, se non si è più grossi del partner, è quasi impossibile muoversi ed applicare la fluidità e le geometrie delle forme, e sezioni, senza possedere una giusta e rigorosa struttura.
Durante allenamenti non collaborativi, lo stress fa aumentare il tono dei muscoli antigravitazionali (gli estensori) e posturali, impedendo al corpo di reagire con naturalezza e fluidità (cioè, come ci si è addestrati nel chi-sao per anni) ad impatti e pressioni inevitabili in un confronto. La cosa si amplifica esponenzialmente in persone, già sotto i 75 Kg.
Nella maggior parte delle scuole che vedo in giro, il problema non è nella differenza dei programmi, o nella diversa interpretazione di sezioni e forme, ma nel modo in cui interpretano il “come” costruire, tenere, e muovere la struttura.
Altrimenti, perché, ci sono più allievi di uno stesso Maestro, con scuole, con così tante differenze sostanziali tra di loro, e non mi riferisco ai metodi di insegnamento, ma, differenze sostanziali su posture e angoli, argomenti dove non dovrebbero esistere tali differenze.
Probabilmente, non avendo raggiunto la particolare comprensione sulla postura più redditizia da tenere, per dare efficacia a movimenti così poco ampi e corti, hanno cercato nelle loro abilità e doti personali, quindi non trasmissibili, metodi e stratagemmi per dare potenza effettiva alla struttura.
Il problema è che a volte sono solo opinioni, legate soltanto a concetti di biomeccanica maccheronica, e non basta avere un fighter nella propria scuola in grado di sconfiggere in risse altri praticanti, dove non si vede niente di simile ad una caratteristica wc, per dire che si insegna l’arte del wc. Sono convinto che un’am sia un percorso che, non può rendere invincibili, ma deve permettere a chiunque un netto miglioramento del suo potenziale, una concreta efficacia, quindi, dimostrabile e riproponibile, e non legata a capacità e doti personali.
Ecco perché ho risposto all’inizio con”senza dubbio la struttura”.
Il metodo che uso nella mia scuola permette di raddoppiare l’efficienza. E per efficienza intendo l’effetto di pesantezza della struttura e le pressioni che braccia e gambe possono esercitare.
Utilizzando come esempio il chi-sao, una situazione d’allenamento che tutti noi conosciamo, e dal quale si pretende di automatizzare dei riflessi condizionati, utili per uscire da situazioni di scontro reale. Il fatto è che con le posizioni usate ”tradizionalmente”, non si può esercitare una pressione superiore al 40% della propria massa corporea. Come si prova, logicamente, ad aumentarla per trovare un minimo di efficacia reale, ecco che il corpo perde il suo equilibrio, perché costretto ad appoggiarsi, sbilanciarsi in avanti; le braccia e le gambe, dovendo sopportare tale carico, si irrigidiscono, perdono la naturale fluidità, e non si riesce a mettere in pratica ciò in cui ci si è applicati per anni.

Osservando queste naturali ed obbligate reazioni, qualcuno ha pensato bene di ”liberarsi della propria forza”, letteralmente. Ed ecco che uno di 100 kg rilassato e senza forza, che fa
chi-sao con uno di 70 kg, rimane fluido e riesce a muoversi quasi come insegnano le forme e le sezioni, quello di 70 kg, si vede costretto a pareggiare i 30 kg in meno di massa, esercitando forza, pressione o come volete chiamarla, limitando la propria capacità di movimento e quindi la fluidità. E come al solito il più forte vince sul più debole.
In questa normale situazione, è mio parere, dimenticare il concetto del “cedere” così come viene interpretato ed allenato nel chi-sao, assolutamente non attuabile nella maggior parte dei casi di scontro reale.
Le corrette interpretazioni delle biomeccaniche della siu-nim-tao e della cham-kiu, permettono a chiunque, con duri e pesanti lavori sul proprio corpo (kung-fu), di raddoppiare, e qui letteralmente, la capacità di esercitare pressioni, mantenendo le articolazioni libere di muoversi con fluidità, proprio come vengono eseguite le forme e sezioni.
Ora è possibile “cedere”, perché, se, e solo se l’avversario è più forte, non è lui che mi spinge, non sono io che mi sposto, ma sono le mie pressioni che non potendo andare avanti, muovono il mio corpo su altri angoli (wei wu wei), mantenendo continuamente pressione “in avanti”, verso il mio avversario, che è sempre costretto a muoversi con un consistente sovraccarico. E tutto questo muovendosi fluidi e rilassati.
Purtroppo la divulgazione dei principi e metodi delle biomeccaniche weac, ha avuto un lungo stop a causa di un brutto incidente motociclistico, all’inizio del 2003, che mi ha tenuto sulle stampelle per più di 22 mesi, situazione nella quale, molti allievi si sono visti costretti a trovare nuove strade, fortunatamente non tutti. E solo da circa due anni sono in grado di dimostrare la bontà di tali studi.
Quali sono i concetti di combattimento su cui è focalizzata la tua scuola?
Tutte le arti marziali sono basate, obbligatoriamente, su i medesimi principi. Principi legati all’anatomia, fisiologia, cinesiologia e biomeccanica, alla psicologia applicata allo stesso strumento, il corpo umano. Quindi non potrò mai dire “ il concetto della mia scuola è…”
Ritengo il wc una magnifica ed evoluta arte marziale taoista, dove, con il suo sapere, e programmi, è possibile rintracciare e vivere tutta la sapienza di un grande sapere racchiuso nell’arte dell’inganno. Nella sua efficacia di movimento, è possibile riscoprire l’intelligenza dei “36 stratagemmi”. E in questo modo insegno i concetti filosofici e marziali.
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, il concetto della mia scuola, è molto più legato al “come e perché” che sul “cosa e quando”. E questo, proprio perché, utilizzo una metodica per addestrare la struttura, che porta tutti i miei allievi e chiunque, ad un aumento considerevole della capacità di sviluppare energia e pressione, con qualsiasi tecnica o stile.
In tutti i miei corsi, tutti praticano le tre forme e l’uomo di legno, chiaramente, ognuno con le abilità possedute al momento, proprio perché, il rendimento e l’efficacia reale, non risiede nella “sola” conoscenza nozionistica (altrimenti solo coreografica), ma nell’acquisire, con l’aiuto di tutti i programmi, le abilità, quindi, i presupposti necessari per far funzionare il wc ad arte.
Una volta acquisite, poi, ognuno decide il livello a cui portarle, anche in funzione del tempo e caratteristiche personali.
Ci puoi dire qualcosa sul “Luk Dim Poon Kwan”?
Sembra che il bastone del wc si sia coperto di un alone di mistero, quasi leggenda, nel suo percorso attraverso le varie epoche.
Soprattutto da quando la tecnologia ha permesso a foto e video di catturare la realtà, sembrano essere scomparsi i “RE del bastone lungo”.
Infatti l’arma, che risulta più lunga del tradizionale bastone ad una punta dello shaolin, forse, proprio perché modificatosi sulla giunca rossa dove si utilizzavano remi e pali per manovrarla, risulta pesante, e anche il solo “impugnarla”, crea disagi nel mantenimento dell’equilibrio.
E come si vede in tanti video, dove, mentre è facile coreografare il wc a mani nude in scambi super veloci e spettacolari, ottimi, forse per vedere gli schemi, ma pessimi per chi pensa di mostrare l’efficacia del wc in un vero scontro, al contrario, è impossibile farli con il lungo bastone, dato il peso che ha, anche solo nel suo essere passivo, e infatti si assiste a dimostrazioni di alcuni movimenti per rappresentare i concetti dei sei punti e mezzo (e anche qui ci sarebbe da parlare sull’avvolgere, sbarrare, puntare, etc), ma privi di un qualsiasi tipo di potenza ed efficacia. Cosa che in realtà dovrebbe essere ben visibile nei movimenti, anche a vuoto, di un esperto.
Sembra logico ed ovvio riportare il problema alla non perfetta interpretazione delle note direttive sul come costruire e muovere la struttura. Questa benedetta struttura, capace di dare peso, potenza e pressione alle tecniche e movimenti a mani nude e, con il dovuto potenziamento, alle armi. Ecco perché le armi sono, e specialmente il bastone lungo, l’ultimo programma del repertorio wc. Quasi fosse una specie di prova finale per vedere se si è capito l’essenza della struttura e l’intelligenza strategica dell’arte (cambiare forma per mantenere il principio immutabile, da notare nel caso specifico delle armi del wc, le loro opposte caratteristiche).
Da notare, è anche, come nel bastone del wc, i sei punti e mezzo siano attuati con un ridotto numero di elementi tecnici-motori (ci si potrebbe quasi rimanere male) motivata dalle dimensioni modificate. Infatti il bastone ad una punta shaolin (circa un metro più corto), o anche la lancia, pur avendo gli stessi principi, hanno molti più elementi tecnici, proprio dovuti alla loro maggiore dinamicità.
Da sfatare, a mio avviso, il mito del footwork nelle armi. Gli stessi elementi si trovano in tutti i programmi da principiante del wc a mani nude, che ovviamente, con le armi, vengono eseguiti con vestiti esterni apparentemente diversi, utili però, ad abbattere gli ultimi schemi e limiti interpretativi di un praticante wc.
Ci puoi dire qualcosa sui Bart Cham Dao?
I coltelli, a differenza del bastone, hanno un rapporto con il wc a mani nude molto più intimo e diretto. Probabilmente si sono sviluppati insieme, fin dall’inizio, con gli stessi meccanismi strutturali e principi, influenzandosi a vicenda.
Infatti, nelle applicazioni dei coltelli, si possono vedere tecniche molto simili a quelle a mani nude.
Questo è il motivo, perché, da un punto di vista marziale, le armi nel wc, sono e devono essere perfezionate alla fine dei programmi a mani nude, e soprattutto, dopo il chi-gerk e l’uomo di legno.
Nulla toglie che molte cose possano essere fatte anche prima. L’escrima che insegno nella mia scuola è costruito anche su concetti, esercizi ed applicazioni delle due armi del wc.
C’è da sottolineare, ancora una volta, che ciò che rende uniche e particolari le armi del wc, è, appunto, la caratteristica di sapersi muovere con le armi in contatto con quelle dell’avversario, appiccicate, quindi, utilizzando non solo tecniche percussive.
Per ciò, è impossibile pensare di mettere in pratica le tecniche con armi senza aver prima acquisito una stabile, potente e dinamica struttura nel corpo a corpo. La SNT insegna come stare in piedi, la CK insegna come camminare, e la BT il correre, e completa le potenzialità motorie.
Le storie del footwork delle armi, possono essere fatte risalire al fatto che, nel combattimento coltelli contro bastone, chi usa i coltelli, che in questo caso rappresentano, solo apparentemente, l’aspetto del più piccolo, meno potente, ma più veloce, dinamico e fluido, è costretto a chiudere la distanza del bastone, che rappresenta, solo apparentemente, l’aspetto del più grande, forte, e nella sua natura, più pesante e rigido.
Le armi, possono essere considerate, l’ultimo anello per completare la comprensione di un taoismo operante, incessantemente percepito nell’agire del wc.
Comunque, con un buon insegnante, possono potenziare struttura, strategia e tecnica del marzialista.